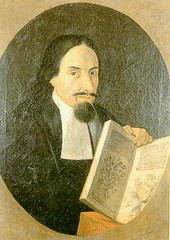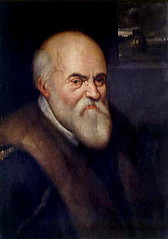Botanici del Rinascimento tra Italia e Germania
Silvia Fogliato
La botanica moderna (ma ci vorrà ancora più di un secolo perché si incominci a chiamarla così) muove i primi passi nell’ultimo scorcio del Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, prima nell’alveo della filologia umanistica come riscoperta dei testi antichi, poi nelle facoltà di medicina dove vengono istituiti i primi corsi sulle piante officinali. Grazie a un grande didatta come Luca Ghini si dà i due strumenti fondamentali che usa ancora oggi: l’erbario e l’orto botanico; intanto al di là delle Alpi, in Germania, impara come sfruttare le risorse dell’arte della stampa per produrre i primi libri illustrati con immagi realistiche. Nel nostro percorso conosceremo meglio alcuni protagonisti di questa “botanica in culla”, molti dei quali sono ingiustamente dimenticati.
Leonhart Fuchs ][ L’erbario con immagini vive di Otto Brunfels ][ Pietro Andrea Mattioli ][ Bartolomeo Maranta, Gian Vincenzo Pinelli e il Giardino della Montagnola ][ Ulisse Aldrovandi e il primo museo di scienze naturali ][ Luca Ghini: un giardino per l’estate, un erbario per l’inverno ][ Botanici del Rinascimento: Niccolò Leoniceno ][ Antonio Musa Brasavola, medico sperimentatore

Botanici del Rinascimento: Leonhart Fuchs
Tra i “padri tedeschi della botanica”, il più noto è indubbiamente Leonhart Fuchs (1501-1566), che ha anche avuto in sorte di donare il suo nome a piante amatissime: le fucsie. Era bavarese, quindi nato in una regione rimasta sostanzialmente fedele al cattolicesimo, ma, come quasi tutti gli altri botanici tedeschi del Cinquecento, anch’egli aderì al Protestantesimo, una decisione che condizionò le sue scelte pubbliche e private. Caso non raro alla sua epoca – quando il corso di studi differiva profondamente da quello odierno e solo i più dotati potevano studiare - fu una specie di fanciullo prodigio. Già a 12 o 14 anni frequentò i corsi di filosofia e storia naturale all'Università di Erfurt.

Botanici del Rinascimento: Niccolò Leoniceno
La botanica (che all’epoca nessuno si sognava di chiamare così) ri-nasce nel Rinascimento, nelle vesti ancillari di medicina farmaceutica, ovvero come studio delle piante da cui si ricavavano medicamenti. E, se non suo padre, almeno suo nonno può essere considerato il medico veneto Niccolò da Lonigo, meglio noto con il nome umanistico Niccolò Leoniceno (1428-1524): nonno per la sua veneranda età (morì ultranovantenne dopo aver insegnato per oltre sessant’anni all’università di Ferrara) e per essere stato il maestro di almeno due dei “padri della botanica”: sicuramente il tedesco Euricius Cordus e probabilmente l’italiano Luca Ghini.

Antonio Musa Brasavola, medico sperimentatore
Niccolò Leoniceno ebbe vita lunghissima (si spense novantaseienne e fu attivo fino a tardissima età) e poté educare al suo metodo innovativo diverse generazioni di studiosi, creando una vera e propria scuola di medici-filologi presso lo Studio ferrarese. Tra tutti il personaggio più celebre è senza dubbio Antonio Musa Brasavola (1500-1555). Di famiglia nobile e di genio precoce, a soli diciannove anni si laureò in filosofia e medicina.
Entrato al servizio dei duchi Alfonso I e Ercole II, accompagnò quest’ultimo in Francia dove ebbe modo di dimostrare le sue conoscenze enciclopediche e la sua abilità dialettica in tre giorni di discussione de quodlibet scibile (ovvero su qualsiasi argomento, a scelta del pubblico) di fronte ai dottori della Sorbona; ammirato, il re Francesco I gli conferì la croce di San Michele e lo ribattezzò Antonio Musa, vedendo in lui la reincarnazione del sapiente medico dell'imperatore Augusto.
Luca Ghini: un giardino per l’estate, un erbario per l’inverno
Rifondata da medici-filologi come Niccolò Leoniceno, la botanica nasce come ancella della medicina. A legarla a questo ruolo è la riscoperta e la valorizzazione di Dioscoride; tuttavia, l’introduzione dell’insegnamento di Materia medica nel curriculum dei futuri medici le fa anche compiere il primo passo verso l’emancipazione, con l’istituzione presso diverse università prima di corsi, poi di cattedre di botanica farmaceutica.
Botanici del Rinascimento: Ulisse Aldrovandi e il primo museo di scienze naturali
Silvia Fogliato
Tra i tanti meriti di Luca Ghini, uomo generoso e grande didatta, c’è anche aver saputo trasmettere i suoi metodi a un folto gruppo di allievi, molti dei quali ebbero un ruolo importante nella ri-nascita degli studi naturalistici del secondo Cinquecento. Tra quelli italiani i più celebri furono Andrea Cesalpino, Ulisse Aldrovandi e Bartolomeo Maranta, che erano anche quelli più vicini e più affezionati al maestro.
Abbiamo già incontrato Andrea Cesalpino nella serie dedicata alla classificazione delle piante; in attesa di conoscere meglio anche il napoletano Maranta, ora tocca al più estroso del trio, quello che oltre ad essere uno scienziato di spessore era anche indubbiamente un “personaggio”: il bolognese Ulisse Aldrovandi (1522-1605). Quando decise di diventare naturalista, aveva alle spalle un’adolescenza e una giovinezza inquiete. E allo studio della natura si convertì non sulla strada di Damasco, ma tra le bancarelle del mercato del pesce di Roma.
Rinascimento napoletano: Bartolomeo Maranta, Gian Vincenzo Pinelli e il Giardino della Montagnola
Silvia Fogliato
Tra gli allievi di Ghini, oltre a Cesalpino e Aldrovandi, certamente i più vicini al maestro e i più diretti continuatori della sua opera, un altro personaggio di spicco è il napoletano Bartolomeo Maranta (1500-1571). Tanto più interessante in quanto intorno a lui si aggregò un vero e proprio circolo di appassionati di scienze naturali, di cui egli fu in un certo senso il teorico.
Nato a Venosa, si formò come medico all'università di Napoli, raggiungendo un'altissima reputazione professionale (si dice che fosse in grado di diagnosticare una malattia solo dall'aspetto del paziente, prima ancora di sentirgli il polso) tanto che, forse tra il 1535 e il 1539, sarebbe stato nominato medico di corte di Carlo V. Per quanto fosse un professionista affermato e fosse ormai sulla cinquantina, tra il 1550 e il 1554 si spostò a Pisa per studiare con Luca Ghini.

Botanici del Rinascimento – Pietro Andrea Mattioli
Storia di un bestseller
Non c’è dubbio che i Discorsi di Pietro Andrea Mattioli (ovvero il suo commento alla Materia medica di Dioscoride) siano stati il più grande bestseller della scienza rinascimentale. In un’epoca in cui un libro che vendesse 500 copie era già un successo, l’opera del medico senese, nel trentennio tra la prima edizione e la morte dell’autore (1544-1578) nelle sue varie versioni ne vendette 32.000. Fu un trionfo senza precedenti, ricercato con tenacia, in primo luogo dall’autore stesso che fece del suo libro un vero e proprio work in progress che ad ogni nuova versione si arricchiva di nuove piante e di commenti sempre più dettagliati. Ma molto contarono l’abilità commerciale dell’eccellente editore veneziano Valgrisi, che si giovava di una distribuzione in grado di raggiungere molti paesi europei, e la protezione dei potenti, primo fra tutti lo stesso imperatore.
L’erbario con immagini vive di Otto Brunfels
Nell’area tedesca, Magonza fu presto superata come centro di produzione del libro a stampa da Strasburgo, all’epoca una città libera dell’Impero. Intorno al 1458 Johannes Mentelin vi aprì una tipografia che tra il 1461 e il 1462 allestì una Bibbia monumentale, seguita da una notevole produzione di testi sacri. Ma la grande specialità di Strasburgo divennero i libri illustrati in lingua volgare, che poterono giovarsi della importante tradizione artistica strasburghese e della presenza in città di abili scultori, pittori e incisori.
La città renana, punto d’incontro tra la Francia, la Germania e le Fiandre, era uno dei maggiori centri di diffusione dell’Umanesimo; presto divenne anche una delle capitali della Riforma. Nel 1519 le tesi di Lutero vennero affisse alle porte della cattedrale, nel 1525 la città adottò la Riforma e nel 1532 sottoscrisse la Confessione augustana. Proprio a quegli anni di svolta risale il secondo e decisivo soggiorno nella città alsaziana del protagonista di questa storia, Otto Brunfels (1488 ca.-1534), il primo in ordine di tempo dei tre «padri tedeschi della botanica».